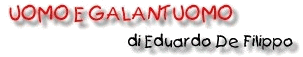
|
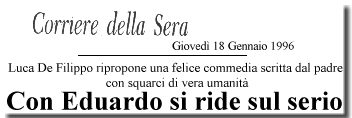 di Giovanni Raboni Ci sono alcuni casi, pochissimi, in cui al recensore piacerebbe potersi limitare a un consiglio amichevole e caloroso: andateci; vi garantisco che c'è da divertirsi. Questo - voglio dire questa messinscena di Uomo e Galantuomo di Eduardo De Filippo diretta e interpretata da suo figlio Luca - è uno di quei casi. Dimenticatevi i comici da cabaret, i comici «surreali», i «nuovi comici», tutti quelli che vanno di moda e riempiono i teatri come effetto secondario del gradimento televisivo; qui, con Eduardo e con Luca, si ride davvero, si ride bene, si ride «sul serio»... Quando, nel 1922, scrisse Uomo e Galantuomo, Eduardo era un giovanissimo attore della compagnia di Vincenzo Scarpetta (che era poi suo fratello, dato che - come tutti sanno - Eduardo era nato da una seconda famiglia, clandestina e al tempo stesso perfettamente normale, del grande Eduardo Scarpetta). È una commedia ancora legata agli schemi, appunto, del teatro scarpettiano, in parte farsesco-popolari e in parte mutuati dal vaudeville francese; ma è già attraversata da vividi lampi di quel realismo, di quella scrupolosa verità ambientale e caratteriale, di quella comicità «umana» su cui Eduardo costruirà a poco a poco il suo teatro. lnsomma, un'opera aurorale, in parte acerba; ma proprio in questo consiste la sua specifica, intramontabile felicità. Prova ne sia che da quando, nel 1926, fu rappresentata per la prima volta, la commedia non fu mai dimenticata, ed ebbe tutta una serie di allestimenti famosi, da quello del 1933 con tutti e tre i fratelli De Filippo - Eduardo, Peppino e Titina - a quella televisiva del '75 in cui Eduardo, ancora protagonista, diresse il figlio Luca nella parte di Alberto, la stessa in cui lui aveva debuttato nel '26 e che aveva poi affidato a Peppino e, nel '65, a Franco Parenti...
Quanto a Luca, è già la seconda volta, in lO anni, che la propone; e chi conosce la toccante metamorfosi attraverso la quale egli è diventato, col passare del tempo, sempre più se stesso e contemporaneamente (e senza alcuna contraddizione) sempre più suo padre, può immaginare con quanta fedeltà' quanta intelligenza, quanta misura egli sappia rendere la bellissima parte di Gennaro, capo comico di una miserabile compagnia di guitti che viene coinvolto senza alcuna colpa nel piccolo scandalo da pochade di un adulterio per ripicca al cui centro c'è Alberto, il giovanotto benestante e nullafacente che finanzia la tournee degli attori. Ma la trama conta fino un certo punto; a sono, ripeto, gli squarci di comicità vera, di comicità umana, che si aprono fra una convulsione narrativa e l'altra: basti pensare alla formidabile scena delle prove, con i battibecchi fra Gennaro e il suggeritore e la geniale gag della porta; o al non meno geniale tormentone della «boatta», il pericoloso recipiente che la compagnia si porta dietro ovunque per cucinare «sul campo» i magri pasti... Lo spettacolo non manca d'eleganza (fin troppa, viene a volte da pensare), con i suoi fondali dipinti e il suo tremante bianco e nero da cinema muto; ma ciò per cui si raccomanda è la carica quasi magnetica di autenticità eduardiana che promana dal protagonista e che contagia in varia misura i suoi compagni, fra i quali vorrei ricordare almeno Angela Pagano nella doppia parte della compagna di Gennaro e di una stramba cameriera, Sebastiano Nardone che è Alberto e poi Nicola Di Pinto, Cristina Liberati, Francesco Biscione, Isabella Salvato. |